Sembra che l’indagine sul borghese in quanto tale – sulla solitudine di massa, sulla alienazione – e il modo di descriverne gli esiti, avendo toccato il loro culmine ne L’uomo dei cinque palloni, non possano avere ulteriori sviluppi. Invece, non solo ne hanno e di ben altra profondità tematica e poetica, ma Dillinger è morto (1969) costituisce una decisiva svolta in quanto risulta nuova anche la sua struttura narrativa, autenticamente “moderna” ossia più adeguata a mostrare il nocciolo della 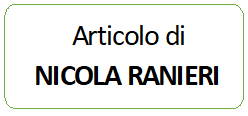 industrializzata società contemporanea.
industrializzata società contemporanea.
Più adeguata, perché il montaggio delle inquadrature non si preoccupa di nascondere o di rendere poco percepibili gli stacchi, anzi, li rimarca; li sottolinea in modo tale che a una qualsiasi immagine un’altra segua come per caso, senza una congruente sequenzialità spaziale e temporale, rispetto a quelle abituali regole della narrazione cosiddetta “classica” in cui il montaggio sembra quasi inavvertibile. Ne deriva perciò una segmentata figuratività dal ritmo sincopato, ma realizzata in maniera fintamente approssimativa e disattenta come nei filmini amatoriali: gli stessi che il protagonista rivede a casa sua – che era, non a caso, l’appartamento in cui abitava il pop-artista italiano Mario Schifano.
Il film – una specie di Kammerspiel – mostra da vicinissimo, come attraverso la lente di ingrandimento, il quotidiano esistere di un disegnatore progettista di maschere antigas. Glauco è un perfetto rappresentante della società industriale di massa. Nella sua professione si annida l’idea stessa di asfissia, di quel continuo senso di costrizione che finisce per attecchire anche nella vita privata, in cui l’assurdo domina sovrano tanto da renderla del tutto integrata a quella sociale e aziendale. Quando torna a casa dopo il lavoro, si dà ai più disparati gesti ripetitivi, automatici al pari di quelli in ufficio: alienati e privi di senso, entro un inesistente rapporto con la moglie sempre annoiata e sfinita dalla sua stessa noia. Sicché lui se ne sta immerso in una compulsiva maniacalità, in un totale solipsismo circondato unicamente da oggetti, feticci, simulacri, immagini di immagini con cui si gingilla attaccandovisi (perlopiù epidermicamente) nel mentre si prepara la cena. Dopo la quale si ritrova pure alle prese con uno svogliatissimo tentativo di gioco erotico con la cameriera, in un succedersi di accadimenti fra di essi irrelati che per un attimo sembrano accendergli un barlume di interesse, subito spento dal basso continuo della sua apatica indolenza: piccoli film girati durante le vacanze, trasmissioni radiofoniche e televisive, musiche in voga…tutto guarda e ascolta con apparente curiosità ma presto sopraffatta dall’indifferenza, dal non appassionarsi alle azioni intraprese e dal perdersi nella normale banalità che svuota di senso qualunque gesto.
E però, all’improvviso, interviene un qualcosa che lo scuote da cotanta abulia.
Ritrova, tra le spezie nella dispensa in cucina, una vecchia pistola avvolta nelle pagine di un giornale in cui vi è un articolo sulla morte del famoso criminale Dillinger e sulla sua epopea di eroe popolare nell’America degli Anni Trenta. Talché il titolo del film ironicamente stride con qualsiasi forma di epicità e il comportamento di Glauco, rispetto a quello di un eroe (sia pure del male) come Dillinger, ne costituisce semmai la parodia ricolma di una desolante ordinarietà massificata.
Tuttavia, per un attimo, egli sembra quasi volerne uscir fuori: mentre sta rivedendo un suo filmino sulla corrida in Spagna, rimane turbato dall’agonia del toro colpito dal matador. Sente quanto profondo sia il contrasto fra quell’autentico vivere-morire e la inautenticità del suo scialbo esistere. Si dà perciò a ripulire la vecchia pistola trovata casualmente, quasi fosse sul punto di accingersi a chissà quale epica impresa. Ma, rimettendola a nuovo, la dipinge di rosso sangue con l’aggiunta di a pois bianchi, tanto che pare un giocattolo in mezzo alle cibarie sul tavolo e al suo infantile armeggiare ludico col corpo della cameriera. E così, di gioco in gioco, Glauco – dominato com’è dalla mancanza di un vero interesse (per qualcosa o qualcuno) e pure da una indolente coazione a ripetere – finisce per compiere un gesto repentino: spara in testa alla moglie dormiente, dopo avergliela coperta con due cuscini e dopo aver mimato allo specchio l’atto di spararsi alla tempia. Ma il tutto avviene solo per noia, poiché lui a niente si appassiona: né al suicidio né all’omicidio. Gioca con la pistola e tediosamente la usa, magari soltanto per provare se funziona.
Non vi è alcun aspetto del comportamento di Glauco che, nello spazio ristretto di un appartamento, possa sfuggire all’occhio indagatore della cinepresa sempre pronta a pedinarlo da presso (come fosse un suo coinquilino intento a osservarlo) secondo la concezione neorealistica del cinema à la Zavattini. Che però Ferreri reinterpreta così liberamente da farne quasi la parodia del pedinamento. E reinterpreta con altrettanta libertà una sequenza del film Illibatezza di Roberto Rossellini. Infatti, mentre la cita esplicitamente – mostrando pure lui il protagonista intento a proiettare dei filmini e a toccarli con le mani –, si capisce che il vero riferimento per Marco Ferreri è però la tetralogia (da L’avventura a Il deserto rosso) di Michelangelo Antonioni, il massimo regista della cosiddetta modernità, che ha analizzato – in maniera nuova e originalissima – i sentimenti ormai divenuti solo “pubbliche relazioni” nella società industriale avanzata in cui la noia attanaglia gli esseri umani, lasciandoli in preda al non saper che fare.
Tuttavia in Dillinger è morto la modernità viene figurata secondo uno stile e una poetica capaci di reinventare sia il che cosa sia il come soprattutto. Perché le immagini, non solo vengono toccate con le mani, ma sono proiettate in modo tale che possano moltiplicarsi, espandendosi fuori dallo schermo. Ovvero, secondo l’idea di cinema espanso.
Un’idea questa che, sebbene non pertenga solamente al cinema, trova tuttavia proprio nella costruzione cinematografica la sua maggiore possibilità di sviluppo, poiché al piano dell’espressione di un film concorrono quasi sempre molteplici forme espressive.
Ogni singola inquadratura, infatti, può contenere (perfino simultaneamente) testo, disegno, fotografia, immagine in movimento: cioè tanti elementi eterogenei combinati per incastro entro un unico spazio. Dei quali elementi però – che si tratti di singoli inserti oppure di svariate sovrapposizioni, sia in trasparenza e sia fra di esse in contrasto – difficilmente si può tentare un’analisi al di fuori della loro dinamica temporale. D’altra parte, pure la sintassi visiva risponde alla logica della iper-mediazione, appunto perché sono elementi multi-mediali il cui montaggio sempre più si spinge verso logiche miste, secondo criteri non-lineari e non-sequenziali allorquando le immagini plurime si sovrappongono e gli schermi si moltiplicano – tendenzialmente all’infinito – per cercare di riprodurre la ricchezza sensoriale della umana esperienza o addirittura di ampliarla oltre ogni limite: oltre il limite persino dei sogni. Come avviene, a esempio, nel cinema di Peter Greenaway e particolarmente in Prospero’s Books. L’ultima tempesta (1991), dove il progressivo complicarsi delle scritture interagenti travalica a tal punto il fare estetico da rischiare di stravolgerlo in un fare meramente tecnologico, anche per eccesso di intellettualismo e di un’arte combinatoria fine a se stessa.
Invece, in Dillinger è morto avviene l’esatto contrario: l’idea di cinema espanso nasce proprio in funzione anti-intellettualistica e, soprattutto, dal rifiuto delle combinazioni macchinose e fantasmagoriche. Secondo Ferreri, questo suo film (così negativo e tragico) intende semplicemente ricordarci che – in un mondo votato all’autodistruzione – la rivoluzione bisogna farla nella realtà e non nella finzione cinematografica. La quale consiste nel portare sulla scena non già le cose ma la loro messa in forma, che spesso eccede in uno sterile formalismo. Ne deriva, quindi, una duplice impossibilità: sia quella di decifrare la realtà, sia quella di evaderne. Ed è ciò che capita a Glauco, il cui nome rimanda alle divinità marine, alla navigazione, agli Argonauti e, principalmente, all’occhio inteso come sguardo profetico.
Di un simile sguardo, in effetti, il disegnatore progettista ne rappresenta la patologia: l’accecamento per eccesso del vedere e del sentire attraverso i moderni mezzi audiovisivi con cui egli gioca, come in preda a un delirio di onnipotenza o piuttosto di una vera e propria schiavitù. Sicché, non le cose e le persone egli vede e ascolta, bensì i loro simulacri.
Le immagini e i segni dei segni li scambia, infatti, per oggetti reali – nel frattempo la ricerca di senso gli si trasforma nel labirinto del suo aggirarsi tra comportamenti maniacali e i tic nervosi dell’artista che lui si figura di essere. Non diversamente, peraltro, dai pop artisti in genere o dal fotografo warholiano di Blow up.
Questa vicenda di alienazione – che si svolge nel chiuso di un appartamento – ha un prologo, ambientato nell’ufficio dove il protagonista lavora e distrattamente ascolta l’amico e collaboratore che gli legge alcune sue riflessioni scritte su L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, cioè su un mondo, non solo unidimensionale, ma in cui non si può più vivere senza indossare la maschera antigas.
Poi la vicenda si chiude con un epilogo, ovvero con la spasmodica voglia di libertà, di uscire dall’asfissia: reale e metaforica.
Ma la libertà, per l’uomo, implica la necessità di passare attraverso il rapporto con la donna. Si tratta del tema ricorrente in quasi tutti i film di Ferreri. In questo, il protagonista risulta del tutto incapace di avere relazioni con le due donne, chiuse in se stesse, nel mistero della loro femminilità. E lui, che sembra come aver perso la virilità, regredisce all’infanzia per sfuggire all’angoscia. Perciò, altro non fa che giocare: pure con un finto serpentello, quale sostituto del suo inesistente organo sessuale.
L’intero film trabocca di filmini, come giochi sostitutivi di rapporti ormai impossibili.
Così congegnandolo e volutamente esagerando, il regista mette in scena la desolazione più totale: la morte di qualsiasi eroicità in un’epoca che ne risulta priva, giacché si è dissolta financo quella in forma banditesca impersonata (a esempio) da un eroe negativo à la Dillinger.
L’epilogo quindi – al contrario di quel che sembra – non è il viaggio verso il rosso della prospettiva rivoluzionaria o di un eroico volersi liberare da tanta desolazione, bensì la fine di qualsivoglia alternativa al mondo alienato; anche se Glauco – al termine della notte culminata con l’uxoricidio – pare intenzionato a imboccare la strada per emanciparsene. Aprendo infatti la finestra all’aria mattutina (che irrompe nel chiuso asfittico del suo claustrofobico appartamento) decide, non solo di andar via da casa e da Roma, ma pure dall’universo urbano-industriale.
Porta con sé pochissime cose, in un’unica borsa. Dal collo gli pende sul petto una vistosa collana da antico guerriero mitologico. È l’inconfondibile segno del votarsi a una grande impresa: uscire da sé e da ogni precedente rapporto.
Si guarda per un’ultima volta in uno specchio ovale tenendolo in pugno per il manico e, quando lo gira sul retro in argento, dà una rapida occhiata all’effige della testa di donna scolpitavi, a quell’eterno femminino che lui intende lasciarsi per sempre alle spalle.
Non appena fuori dal portone, gli capita di trovare sul cofano della macchina la poltiglia spiaccicata delle probabili interiora di un uccello. Con sguardo da aruspice le osserva per un istante, interrogandosi perplesso del proprio futuro. Ma il dado è ormai tratto.
In men che non si dica giunge a Porto Venere. E qui si sofferma di fronte alla lapide posta all’ingresso della Grotta dell’Arpaia o di George Gordon Byron per leggere la scritta che ne ricorda l’ardimento di nuotatore e l’immortalità poetica.
Cosicché in Glauco cresce l’irrefrenabile desiderio di uscire dalla sua piatta esistenza e di emulare le gesta dell’eroe romantico per eccellenza. Con indosso il costume da bagno e la collana da antico guerriero, si tuffa nella liquida azzurrità e nuotando si immagina di essere ciò di cui il suo stesso nome è il simbolo: figlio del dio del mare e pescatore nonché guerriero omerico al pari di Lord Byron, che dal promontorio di Arpaia amava pensare di trovarsi, al contempo, su quello di Capo Sunio tra le colonne del tempio di Poseidone, indorate dal sole del mattino che radioso illuminava il cielo, il mare e la terra all’alba di una intera civiltà.
Mentre è preso in tali pensieri e si figura quale emulo del grande poeta, autore de Il corsaro, Glauco vede quasi per magia un veliero poco oltre le rocce.
A nuoto arriva a portata di voce dei marinai intenti a gettare in mare la salma del cuoco avvolta in un telo bianco. E cerca di convincerli a farsi prendere per sostituire in cucina il defunto. Ma, una volta a bordo, viene a sapere dal nostromo che la decisione di assumerlo spetta al capitàno: la avvenente e giovanissima proprietaria del grande yacht in partenza per Tahiti.
È lei che, con aria da padrona, subito si impossessa della sua aurea collana da eroe antico, giacché le sta proprio bene sul costume da bagno verde. In cambio gli concede di restare (ma solo in prova) e senza parlargli direttamente, bensì impartendo l’ordine al nostromo: «Fatemi fare una mousse al cioccolato».
E il nostromo, obbedendo, provvede ad accompagnare in cucina Glauco, che prende servizio né più né meno degli altri marinai addetti al controllo delle vele dello yacht ormai pronto a salpare tra musichette da turisti in crociera e il rosso di un enorme sole da cartolina. Che però ben presto si muta in un rosseggiare beffardo fino al cinismo, e la musica assume un tono lugubre.
Tahiti, verso cui il vascello naviga, è un indistinto altrove – ubiquo e vaghissimo –tanto agognato quanto inesistente. Sicché il film si chiude con un’inquadratura in negativo: l’immagine geometrizzata di un veliero che, un attimo prima di dissolversi nel rosso sangue della luce solare al tramonto, assomiglia a quel veliero di morte figurato con tratto espressionista da Friedrich Wilhelm Murnau in Nosferatu il vampiro. È la fine di ogni possibile prospettiva. Della quale si avverte l’assenza ma, al tempo stesso, un acuto desiderio di ciò che sembra del tutto improbabile che sia.
