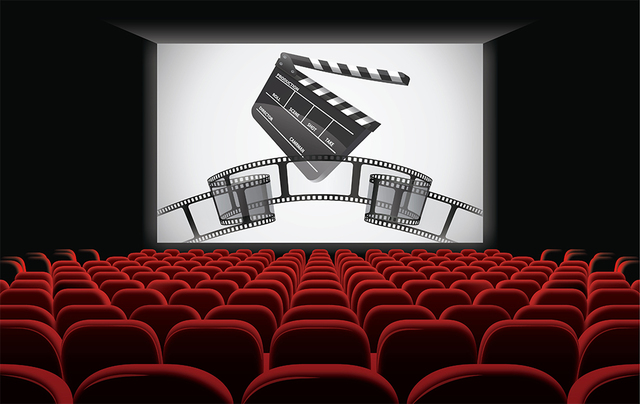La cinematografia relativa alla Resistenza in Italia è molto ampia e articolata nei vari decenni del dopoguerra. I film di impostazione neorealista, in particolare, realizzati immediatamente a ridosso dell’evento bellico, contribuiscono, in misura maggiore di qualsiasi altro documento storico, a restituirci il clima drammatico della guerra e dell’occupazione tedesca.
La cinematografia relativa alla Resistenza in Italia è molto ampia e articolata nei vari decenni del dopoguerra. I film di impostazione neorealista, in particolare, realizzati immediatamente a ridosso dell’evento bellico, contribuiscono, in misura maggiore di qualsiasi altro documento storico, a restituirci il clima drammatico della guerra e dell’occupazione tedesca.
Alle tragiche vicende che accompagnano quest’ultima a Roma nel 1944, e in particolare alle feroci torture praticate nella prigione di Via Tasso, si ispira il film di Roberto Rossellini Roma città aperta (1946), uno dei capolavori del neorealismo e probabilmente il più celebre dei film sulla Resistenza. Esso ha contribuito in maniera determinante, accanto alle altre produzioni neorealiste (in particolare Paisà, dello stesso Rossellini, e Sciuscià di Vittorio De Sica) ad accreditare all’estero un’immagine dell’Italia ben diversa da quella fornita dal fascismo. Il film risente in misura notevole degli eventi che in quel periodo sconvolgono il paese e scuotono le coscienze, segnando una rottura netta rispetto al torpore del ventennio. Il cinema italiano risulta potentemente influenzato da quelle vicende, con il conseguente scardinamento di un’industria cinematografica di regime che aveva bandito tutto ciò che non risultasse in linea con la retorica fascista, la quale si manifestava prevalentemente nei film di guerra dominati dalla “splendida morte degli eroi”. Girato con pochi mezzi, tra l’estate del 1944 e la primavera del 1945, subito dopo la  liberazione della capitale, con la sceneggiatura di Sergio Amidei, Federico Fellini e Celeste Negarville (l’esponente comunista che alcuni associano alla figura di uno dei protagonisti, Manfredi), il film di Rossellini rappresenta invece la morte nella sua reale tragicità, nel contesto di situazioni appena vissute, con le case distrutte dai bombardamenti e gli altri segni della guerra tuttora visibili. Contemporaneamente, ai personaggi provenienti dalle file dell’aristocrazia e dell’alta borghesia, protagonisti della cinematografia dei decenni precedenti, si sostituiscono figure schiettamente popolari come quelle della sora Pina, di don Pietro, delle donne che saccheggiano una panetteria, dei bambini che (al pari degli scugnizzi napoletani) fanno saltare un treno. Data la sua vicinanza temporale con gli eventi narrati, il film rappresenta una preziosa fonte per la loro conoscenza, documentando in particolare la vita quotidiana in un quartiere popolare romano; gli sconvolgimenti provocati in un caseggiato a causa della presenza di un clandestino (un motivo ricorrente nella cinematografia resistenziale); il divario tra le precarie condizioni di vita dei ceti popolari (in particolare di quelli che hanno perso il lavoro) e quelle, ben più agiate, dei collaborazionisti e di coloro che praticano il mercato nero, messi al bando dal resto della società; gli effetti della guerra combattuta all’interno di una città (la guerra partigiana “per bande”, condotta dai GAP), assolutamente più devastanti rispetto a quelli prodotti da precedenti esperienze belliche (i morti provocati da questo tipo di guerra infatti non sono più quelli anonimi uccisi dai bombardamenti bensì vittime designate del terrore scatenato dall’occupante nazista). Particolarmente sconvolgente è la scena del rastrellamento (che ricorda quello del ghetto ebraico nell’ottobre del 1943): l’immagine di Anna Magnani, nei panni della popolana, riversa sull’asfalto con l’abito nero appena sollevato, resta uno dei simboli più terribili e celebri di tutta la storia del cinema. La passione militante del regista conferisce inoltre al suo capolavoro un tono inequivocabilmente celebrativo, in un momento in cui si ritiene fondamentale sostenere la lotta di liberazione, ancora in corso nel nord del paese. La caratterizzazione dei personaggi del film è molto netta. Da una parte, abbiamo due figure di limpidi eroi che combattono per la libertà, uniti nell’opposizione al nazifascismo e nel sacrificio della vita: l’ingegnere comunista e il prete di borgata, incarnazione delle due componenti fondamentali della Resistenza italiana, quella di derivazione marxista e quella di ispirazione cattolica, viste come protagoniste, dopo il ventennio fascista, della rinascita del paese e della dialettica politica del dopoguerra. Dall’altra ci sono i nazisti, considerati, per la loro naturale disposizione al vizio (si pensi alla generale atmosfera di decadenza morale che
liberazione della capitale, con la sceneggiatura di Sergio Amidei, Federico Fellini e Celeste Negarville (l’esponente comunista che alcuni associano alla figura di uno dei protagonisti, Manfredi), il film di Rossellini rappresenta invece la morte nella sua reale tragicità, nel contesto di situazioni appena vissute, con le case distrutte dai bombardamenti e gli altri segni della guerra tuttora visibili. Contemporaneamente, ai personaggi provenienti dalle file dell’aristocrazia e dell’alta borghesia, protagonisti della cinematografia dei decenni precedenti, si sostituiscono figure schiettamente popolari come quelle della sora Pina, di don Pietro, delle donne che saccheggiano una panetteria, dei bambini che (al pari degli scugnizzi napoletani) fanno saltare un treno. Data la sua vicinanza temporale con gli eventi narrati, il film rappresenta una preziosa fonte per la loro conoscenza, documentando in particolare la vita quotidiana in un quartiere popolare romano; gli sconvolgimenti provocati in un caseggiato a causa della presenza di un clandestino (un motivo ricorrente nella cinematografia resistenziale); il divario tra le precarie condizioni di vita dei ceti popolari (in particolare di quelli che hanno perso il lavoro) e quelle, ben più agiate, dei collaborazionisti e di coloro che praticano il mercato nero, messi al bando dal resto della società; gli effetti della guerra combattuta all’interno di una città (la guerra partigiana “per bande”, condotta dai GAP), assolutamente più devastanti rispetto a quelli prodotti da precedenti esperienze belliche (i morti provocati da questo tipo di guerra infatti non sono più quelli anonimi uccisi dai bombardamenti bensì vittime designate del terrore scatenato dall’occupante nazista). Particolarmente sconvolgente è la scena del rastrellamento (che ricorda quello del ghetto ebraico nell’ottobre del 1943): l’immagine di Anna Magnani, nei panni della popolana, riversa sull’asfalto con l’abito nero appena sollevato, resta uno dei simboli più terribili e celebri di tutta la storia del cinema. La passione militante del regista conferisce inoltre al suo capolavoro un tono inequivocabilmente celebrativo, in un momento in cui si ritiene fondamentale sostenere la lotta di liberazione, ancora in corso nel nord del paese. La caratterizzazione dei personaggi del film è molto netta. Da una parte, abbiamo due figure di limpidi eroi che combattono per la libertà, uniti nell’opposizione al nazifascismo e nel sacrificio della vita: l’ingegnere comunista e il prete di borgata, incarnazione delle due componenti fondamentali della Resistenza italiana, quella di derivazione marxista e quella di ispirazione cattolica, viste come protagoniste, dopo il ventennio fascista, della rinascita del paese e della dialettica politica del dopoguerra. Dall’altra ci sono i nazisti, considerati, per la loro naturale disposizione al vizio (si pensi alla generale atmosfera di decadenza morale che  si respira nel comando tedesco), il simbolo del Male assoluto. Manca totalmente invece, in Rossellini, qualsiasi riferimento ideologico alla lotta di classe: in Roma città aperta tutti, ricchi e poveri, combattono contro i tedeschi, mentre i partigiani ricevono consistenti aiuti, oltre che dagli operai, anche da un ricco commerciante, da artigiani benestanti e dal proprietario di un ristorante.
si respira nel comando tedesco), il simbolo del Male assoluto. Manca totalmente invece, in Rossellini, qualsiasi riferimento ideologico alla lotta di classe: in Roma città aperta tutti, ricchi e poveri, combattono contro i tedeschi, mentre i partigiani ricevono consistenti aiuti, oltre che dagli operai, anche da un ricco commerciante, da artigiani benestanti e dal proprietario di un ristorante.
Un’impostazione ben diversa rispetto a quella rosselliniana caratterizza Il sole sorge ancora di Aldo Vergano, uscito nello stesso anno 1946, anch’esso di chiara impostazione neorealista. Lo schema del film, commissionato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) è, a differenza di quello interclassista di Rossellini, di chiara ispirazione marxista, e tende a identificare fascismo e capitalismo. Non è difficile, inoltre, intravedere in esso chiari segnali di preoccupazione per l’incipiente crollo delle speranze di rinnovamento radicale della società accese dalla lotta partigiana. Elaborato da uno dei redattori del quotidiano milanese del Partito d’Azione, Italia Libera, che ha partecipato attivamente, al fianco del suo leader Ferruccio Parri, alla lotta clandestina e all’insurrezione finale, e girato rapidamente tra il 1945 e il 1946, quando lo spirito resistenziale è ancora molto vivo, il film rispecchia fino in fondo l’atmosfera di quegli anni e si caratterizza per l’estremo realismo con il quale vengono descritti ambienti e personaggi. Questi ultimi, in particolare, lungi da qualsiasi tentazione retorica o celebrativa, non risultano idealizzati come eroi, ma sono rappresentati nella loro vera esistenza quotidiana, con le loro contraddizioni, i loro vizi e le loro virtù. Obiettivo principale del film sembra essere quello di analizzare, nel contesto della crisi morale e politica che, durante la guerra, investe le varie classi sociali, e del diverso comportamento da esse adottato nei confronti del movimento di liberazione, le ragioni morali, politiche e sociali che spingono tante persone ad aderire alla guerra partigiana oppure a schierarsi dall’altra parte. Ma, ben più che in Roma città aperta, emerge, nel film di Vergano, la netta differenza tra il tenore di vita delle classi superiori, per nulla intaccato dalla guerra, e gli stenti e i disagi delle famiglie operaie e contadine. E, a differenza che nel film di Rossellini, in cui tutti collaborano alla Resistenza, qui il proprietario terriero e i suoi amici si disinteressano della lotta partigiana, preoccupandosi esclusivamente della propria sorte, e solo quando vedranno la loro proprietà minacciata dall’arrivo dei tedeschi, si decideranno ad appoggiare la causa resistenziale, evitando in tal modo di rendere conto del proprio operato alla fine della guerra.
 Nel corso degli anni Cinquanta, nel clima di scontro creato dalla guerra fredda tra le forze che avevano dato vita alla lotta antifascista, la produzione di film sulla Resistenza tende a diminuire sensibilmente. Tra quelli realizzati in questi anni, si distingue Achtung! Banditi, diretto da Carlo Lizzani nel 1951, che si ispira alla fase più drammatica della lotta di liberazione, quella dell’autunno del 1944. Il film, che, al pari di quello di Vergano, denota una chiara impostazione marxista, rievoca un episodio realmente accaduto a Genova, all’inizio dell’ultimo inverno di guerra. Influenzato dal cinema sovietico, e pur realizzato in un’epoca ancora molto vicina agli eventi narrati, quello di Lizzani è uno dei primi film sulla Resistenza chiamato ad affrontare l’argomento (a differenza di quanto accadeva con il cinema neorealista) con il necessario distacco richiesto da un film “storico”. Ciononostante, il regista adotta uno stile ancora in gran parte neorealista, servendosi altresì di una cospicua dose di materiale documentario e fornendo un’accurata descrizione dell’interno delle fabbriche e della periferia genovese, con i suoi ponti, viadotti, binari. Privilegiando l’azione e le immagini rispetto alle psicologie dei personaggi, esso evidenzia un chiaro intento didattico e celebrativo, in anni nei quali un’egemonia politica conservatrice lavora a rimuovere o a svilire gli ideali di riscatto sociale e di uguaglianza fatti propri dalla Resistenza. Di qui, la presentazione della lotta di liberazione come rivolta corale di un intero popolo, sotto la guida di una classe operaia capace di esercitare la propria egemonia nei confronti della borghesia intellettuale e progressista, dei contadini e delle donne. L’importanza del film è legata anche al progetto neorealista, nato attorno ad esso, di dare vita a una cooperativa di Spettatori Produttori Cinematografici, finanziata, su iniziativa dell’ANPI, da migliaia di operai genovesi (in testa i tranvieri) con azioni da cinquecento lire, allo scopo di favorire la realizzazione di film “scomodi” che l’industria privata non intende realizzare. Il progetto è tuttavia destinato a fallire rapidamente, a causa dei mutamenti dei gusti del grande pubblico, sempre più orientato, in questi anni, verso film melodrammatici e comici.
Nel corso degli anni Cinquanta, nel clima di scontro creato dalla guerra fredda tra le forze che avevano dato vita alla lotta antifascista, la produzione di film sulla Resistenza tende a diminuire sensibilmente. Tra quelli realizzati in questi anni, si distingue Achtung! Banditi, diretto da Carlo Lizzani nel 1951, che si ispira alla fase più drammatica della lotta di liberazione, quella dell’autunno del 1944. Il film, che, al pari di quello di Vergano, denota una chiara impostazione marxista, rievoca un episodio realmente accaduto a Genova, all’inizio dell’ultimo inverno di guerra. Influenzato dal cinema sovietico, e pur realizzato in un’epoca ancora molto vicina agli eventi narrati, quello di Lizzani è uno dei primi film sulla Resistenza chiamato ad affrontare l’argomento (a differenza di quanto accadeva con il cinema neorealista) con il necessario distacco richiesto da un film “storico”. Ciononostante, il regista adotta uno stile ancora in gran parte neorealista, servendosi altresì di una cospicua dose di materiale documentario e fornendo un’accurata descrizione dell’interno delle fabbriche e della periferia genovese, con i suoi ponti, viadotti, binari. Privilegiando l’azione e le immagini rispetto alle psicologie dei personaggi, esso evidenzia un chiaro intento didattico e celebrativo, in anni nei quali un’egemonia politica conservatrice lavora a rimuovere o a svilire gli ideali di riscatto sociale e di uguaglianza fatti propri dalla Resistenza. Di qui, la presentazione della lotta di liberazione come rivolta corale di un intero popolo, sotto la guida di una classe operaia capace di esercitare la propria egemonia nei confronti della borghesia intellettuale e progressista, dei contadini e delle donne. L’importanza del film è legata anche al progetto neorealista, nato attorno ad esso, di dare vita a una cooperativa di Spettatori Produttori Cinematografici, finanziata, su iniziativa dell’ANPI, da migliaia di operai genovesi (in testa i tranvieri) con azioni da cinquecento lire, allo scopo di favorire la realizzazione di film “scomodi” che l’industria privata non intende realizzare. Il progetto è tuttavia destinato a fallire rapidamente, a causa dei mutamenti dei gusti del grande pubblico, sempre più orientato, in questi anni, verso film melodrammatici e comici.
Meno “epico” è Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli, pervaso da una spietata critica nei confronti dell’attendismo di una certa alta borghesia italiana, esclusivamente interessata a conservare, al di là degli sconvolgimenti causati dalla guerra, il proprio potere e i propri privilegi. Tale accentuazione spiega le polemiche sorte intorno ad esso nell’Italia moderata e conservatrice di quegli anni.
Negli anni Sessanta, la cinematografia resistenziale acquista nuovo vigore. Nel clima di “antifascismo militante” innescato dai fatti di giugno-luglio del 1960 a Genova e dalla rivolta contro Tambroni, si torna a indagare sulle lacerazioni indotte dall’8 settembre e sulle ambiguità della borghesia italiana,  mentre contemporaneamente ci si interroga sulle responsabilità della caduta delle illusioni e delle speranze alimentate dalla lotta di liberazione (il motivo della “Resistenza tradita”), già in nuce nel precedente film di Vergano. Tali problematiche sono affrontate, in particolare, nel film di Florestano Vancini La lunga notte del ‘43 (1960). Tratto dal racconto Una notte del ‘43 (1956) di Giorgio Bassani, la sua peculiarità, nella storia del cinema italiano del dopoguerra, consiste essenzialmente nell’aver per la prima volta affrontato gli eventi drammatici di quegli anni senza riferimenti espliciti alla Resistenza e all’occupazione tedesca, ma concentrandosi esclusivamente sulla guerra civile tra italiani, sull’indifferenza con cui molti la osservano dall’esterno e sulle dirette responsabilità dei fascisti nelle rappresaglie, finora attribuite ai soli nazisti. In tal modo, Vancini supera la rimozione di un momento particolarmente delicato della nostra storia nazionale, evitando accuratamente, al tempo stesso, i toni celebrativi, con i quali sino ad allora questi argomenti erano stati affrontati. Analogamente al precedente film di Maselli, ciò che il regista intende mettere in risalto è soprattutto la viltà dei protagonisti: un farmacista, che era stato fascista da giovane, paralizzato non solo fisicamente ma anche moralmente; l’amante della moglie, che dimostra la sua viltà fuggendo in Svizzera e chiudendo gli occhi di fronte alla responsabilità di un gerarca nella morte di suo padre. È un’ignavia che assurge a simbolo del compromesso che la borghesia italiana avrebbe stretto con il fascismo, messo ancor più in luce alla fine del film quando, diciassette anni dopo, l’amante e il gerarca, ormai pensionato, si stringono la mano. Andando oltre il testo di Bassani, Vancini non rinuncia a muovere una feroce critica nei confronti di un’Italia frivola e consumistica (siamo ormai all’inizio degli anni Sessanta, in pieno miracolo economico) che, dimenticando il suo passato, si rivela incapace di riconoscere le proprie responsabilità nel ventennio fascista. Di qui, le dure proteste con cui il film è stato accolto dagli ambienti governativi di quegli anni, esplicitamente coinvolti nell’accusa di aver garantito l’impunità dei crimini fascisti.
mentre contemporaneamente ci si interroga sulle responsabilità della caduta delle illusioni e delle speranze alimentate dalla lotta di liberazione (il motivo della “Resistenza tradita”), già in nuce nel precedente film di Vergano. Tali problematiche sono affrontate, in particolare, nel film di Florestano Vancini La lunga notte del ‘43 (1960). Tratto dal racconto Una notte del ‘43 (1956) di Giorgio Bassani, la sua peculiarità, nella storia del cinema italiano del dopoguerra, consiste essenzialmente nell’aver per la prima volta affrontato gli eventi drammatici di quegli anni senza riferimenti espliciti alla Resistenza e all’occupazione tedesca, ma concentrandosi esclusivamente sulla guerra civile tra italiani, sull’indifferenza con cui molti la osservano dall’esterno e sulle dirette responsabilità dei fascisti nelle rappresaglie, finora attribuite ai soli nazisti. In tal modo, Vancini supera la rimozione di un momento particolarmente delicato della nostra storia nazionale, evitando accuratamente, al tempo stesso, i toni celebrativi, con i quali sino ad allora questi argomenti erano stati affrontati. Analogamente al precedente film di Maselli, ciò che il regista intende mettere in risalto è soprattutto la viltà dei protagonisti: un farmacista, che era stato fascista da giovane, paralizzato non solo fisicamente ma anche moralmente; l’amante della moglie, che dimostra la sua viltà fuggendo in Svizzera e chiudendo gli occhi di fronte alla responsabilità di un gerarca nella morte di suo padre. È un’ignavia che assurge a simbolo del compromesso che la borghesia italiana avrebbe stretto con il fascismo, messo ancor più in luce alla fine del film quando, diciassette anni dopo, l’amante e il gerarca, ormai pensionato, si stringono la mano. Andando oltre il testo di Bassani, Vancini non rinuncia a muovere una feroce critica nei confronti di un’Italia frivola e consumistica (siamo ormai all’inizio degli anni Sessanta, in pieno miracolo economico) che, dimenticando il suo passato, si rivela incapace di riconoscere le proprie responsabilità nel ventennio fascista. Di qui, le dure proteste con cui il film è stato accolto dagli ambienti governativi di quegli anni, esplicitamente coinvolti nell’accusa di aver garantito l’impunità dei crimini fascisti.
Nell’ambito della stessa cinematografia resistenziale degli anni Sessanta, si manifesta anche una chiara volontà di richiamare alla memoria alcune figure di martiri dell’antifascismo. Particolare valore assume, in tale contesto, il film di Gianni Puccini I sette fratelli Cervi (1967), dedicato alla memoria di sette giovani (di età compresa tra i 22 e i 42 anni), figli di Alcide Cervi, capo di una numerosa famiglia rurale antifascista, che vive e lavora a Campegine, nelle campagne del reggiano, i quali, il 28 dicembre del 1943, vengono fucilati per rappresaglia dai tedeschi. Boicottato a lungo dalla censura, il film racconta la storia di una famiglia profondamente influenzata dalla tradizione socialista del primo Novecento, che non nasconde il proprio intransigente antifascismo. Particolarmente efficace nella descrizione dell’ambiente rurale emiliano, il film di Puccini è stato criticato per un certo schematismo ideologico, e per un linguaggio eccessivamente ancorato alla tradizione neorealista, legati soprattutto alla volontà di commemorare  l’eroismo dei sette ragazzi e il dignitoso dolore di papà Cervi. Pur tuttavia esso nasce con finalità anti-retoriche e si propone di attenuare l’alone epico e leggendario che circonda i suddetti personaggi, i quali vengono presentati in tutta la loro umanità, nella vita quotidiana della famiglia, non esenti da timori e incertezze. In particolare vengono messe in risalto l’impazienza e l’impulsività dei giovani, che li portano spesso ad entrare in contrasto con la disciplina del Comitato di Liberzione Nazionale (CLN), e che saranno la causa principale della loro tragica fine.
l’eroismo dei sette ragazzi e il dignitoso dolore di papà Cervi. Pur tuttavia esso nasce con finalità anti-retoriche e si propone di attenuare l’alone epico e leggendario che circonda i suddetti personaggi, i quali vengono presentati in tutta la loro umanità, nella vita quotidiana della famiglia, non esenti da timori e incertezze. In particolare vengono messe in risalto l’impazienza e l’impulsività dei giovani, che li portano spesso ad entrare in contrasto con la disciplina del Comitato di Liberzione Nazionale (CLN), e che saranno la causa principale della loro tragica fine.
Negli anni Settanta, la lettura marxista della Resistenza tende ad accentuarsi ulteriormente, grazie al lavoro di registi quali Lizzani, Montaldo, Bertolucci e altri. Una ricostruzione fortemente ideologica della liberazione trova spazio nella seconda parte del lunghissimo film Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci. In sequenza cronologica con gli eventi descritti nella prima, il regista legge il fascismo e la guerra di liberazione attraverso le vicende personali di due amici, un ricco proprietario terriero e un lavoratore alle sue dipendenze, che subisce, a causa del suo antifascismo, le persecuzioni del potere. I due personaggi rispecchiano simbolicamente, in forma evidentemente didascalica, lo scontro inevitabile tra borghesia e proletariato, destinato marxianamente a concludersi, sia pure in un futuro indeterminato, con la vittoria di quest’ultimo. Il film di Bertolucci non presume tuttavia di ricostruire oggettivamente la storia del XX secolo: anzi, non mancano in esso evidenti falsificazioni e manipolazioni, dal momento che la volontà del regista è piuttosto quella di reinventare in maniera soggettiva, attraverso la fusione di diversi linguaggi cinematografici (da quello sovietico d’avanguardia a quello politico cinese, dal realismo poetico francese al  teatro brechtiano), una propria idea del Novecento.
teatro brechtiano), una propria idea del Novecento.
Intorno alla metà dello stesso decennio, si registra anche un evidente influsso esercitato sulla cinematografia resistenziale da parte del crescente movimento femminista, che contribuisce non poco a ricordare l’impegno delle donne nella lotta di liberazione e a favorire la realizzazione dell’unico film sulla Resistenza che ha come protagonista un personaggio femminile, L’Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo. La vicenda si svolge nel delta del Po, più precisamente nelle Valli di Comacchio, tra l’8 settembre del 1943 e l’inverno del 1944-45. Ispirato all’omonimo romanzo del 1949 dell’ex partigiana Renata Viganò (che già i registi neorealisti avrebbero voluto portare sullo schermo), il film di Montaldo si colloca a pieno titolo nel contesto delle interpretazioni della Resistenza da parte del cinema politico italiano in quegli anni, in particolare nella seconda metà del decennio, quando si afferma una nuova attenzione verso il ruolo delle donne (in particolare delle staffette partigiane) nel movimento di liberazione. Nel momento in cui documenta, inoltre, l’irruzione della grande storia nel mondo contadino, il film mette a fuoco con efficacia le difficoltà e le contraddizioni che animano i rapporti tra la comunità rurale e tutti coloro (soldati sbandati, ex prigionieri alleati, sfollati) che le sono estranei. Il mondo contadino è alle prese con la propria sopravvivenza, nonostante l’indubbio privilegio di cui esso gode nei confronti di chi abita in città: in particolare la possibilità di vendere al mercato nero i prodotti alimentari in eccesso. La solidarietà esternata dai contadini verso i giovani sbandati e renitenti alla leva è incondizionata, mentre il rapporto con i partigiani si rivela più complesso: se infatti inizialmente essi vengono accolti come liberatori, le cose cambiano dopo le prime rappresaglie tedesche, quando tende a prevalere la paura che la presenza dei patrioti attiri i nazifascisti. Ciononostante, dal film si evince che spesso la presa di coscienza del fatto che i partigiani combattano per una giusta causa spinge molti contadini ad abbracciare e sostenere la loro battaglia. Con altrettanta efficacia L’Agnese va a morire affronta il tema dell’atteggiamento degli anglo-americani nei confronti dei partigiani, in particolare dopo il lancio del proclama di Alexander, che provoca scoramento e disperazione tra i compagni di Agnese. Tutto ciò si rivela soprattutto nella scena in cui quattro soldati inglesi assistono impassibili al massacro di un gruppo di partigiani che tentano di raggiungere le linee alleate.
(1-continua)